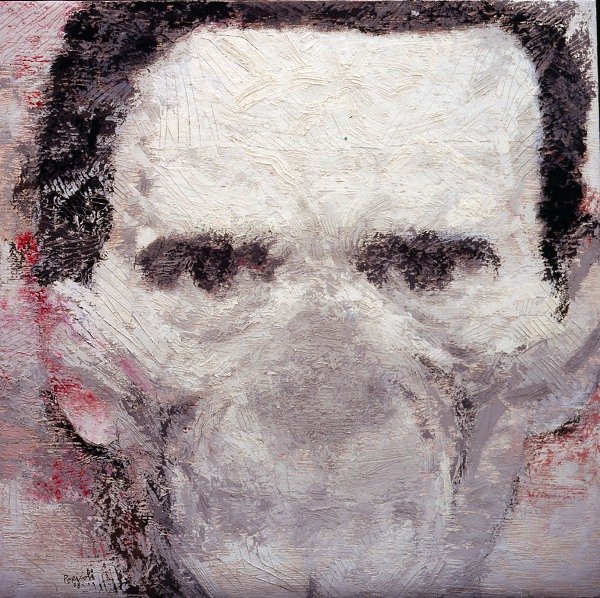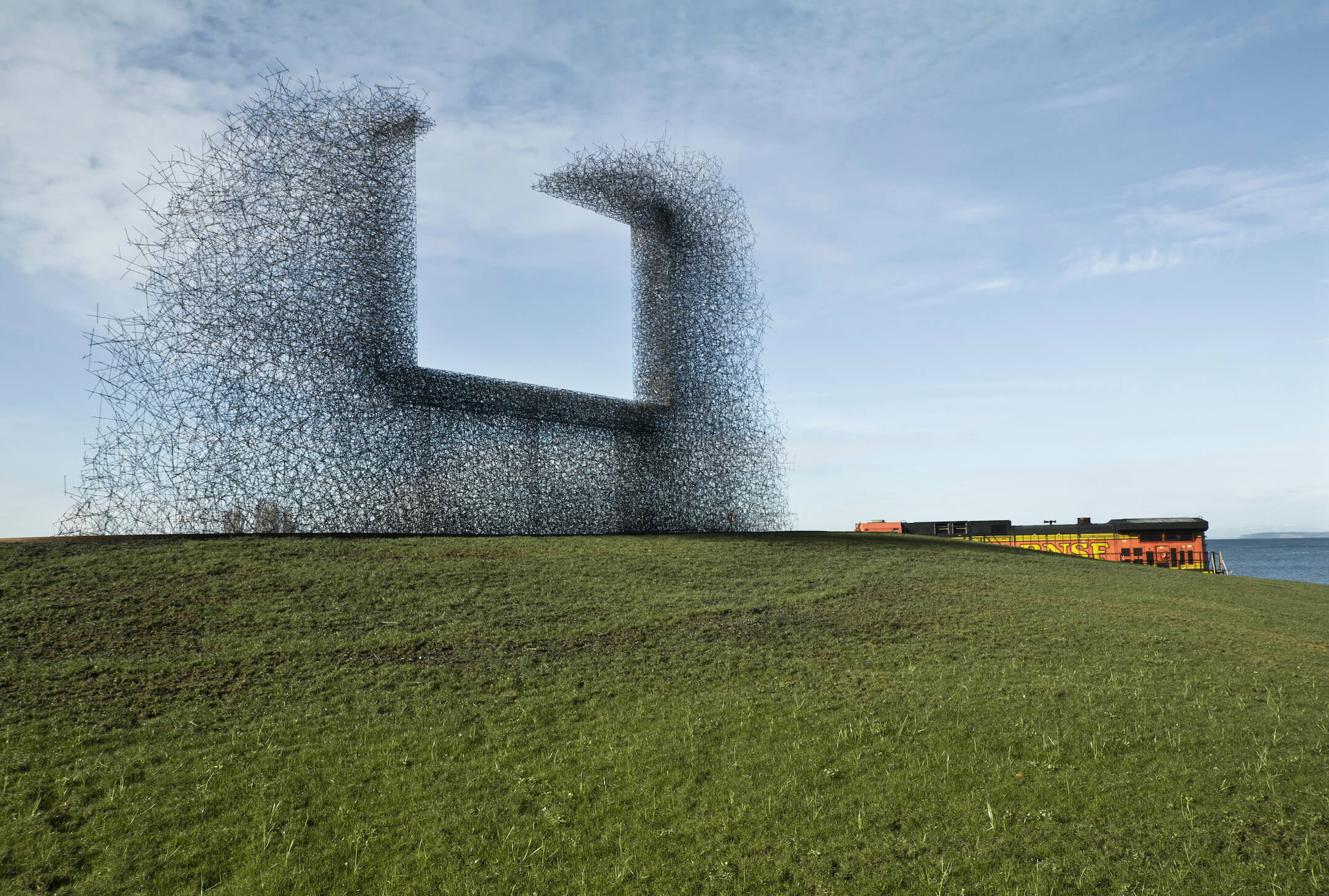Nel dicembre del 2018, nell’ambito delle mie ricerche sul cinema delle donne in Italia, ho intervistato la regista Cecilia Mangini. Entrando in un bar-libreria romano vicino a Ponte Milvio, Mangini si è rivolta con tono gentile ma perentorio al barista, chiedendogli di abbassare la musica. Poi, senza nemmeno darmi il tempo di presentarmi, ha chiesto con un tono un po’ canzonatorio: «Un libro sul cinema delle donne?», come a dire, «e che cos’è?».
Me l’aspettavo. Conoscendo lo scetticismo di molte registe italiane nei confronti della prospettiva di genere e la paura non ingiustificata di essere etichettate come ‘registe done’, ho risposto: «Lo so, per te il cinema è cinema, non è né maschile né femminile, è cinema e basta. Ma puoi negare che essere donna non abbia influenzato il tuo percorso come regista?».
Senza rispondere alla mia domanda, ha iniziato a raccontare dei suoi inizi, di come, per esempio, negli anni Quaranta aveva preso un treno per Roma con l’intenzione di fare domanda al Centro Sperimentale di Cinematografia. Ma sentendosi indirizzare al corso di montaggio o produzione piuttosto che a quello di regia, se n’era andata e aveva comprato una macchina fotografica, ed era poi diventata una fotografa di strada in tempi in cui per strada a suo dire c’erano solo ‘certe’ donne. Poi dalla fotografia era passata al cinema documentario militante. E il resto è storia del cinema, anche se per alcuni nient’altro che un capitolo marginale.
Oggi, molto (non tutto) è cambiato. Da venti anni a questa parte in Italia un numero crescente di donne esordisce alla regia conquistando spazi un tempo dominati quasi unicamente dagli uomini. Tuttavia, anche se sempre più registe riescono a ottenere fondi per produrre la loro ‘opera prima’, e quelle che hanno cominciato decenni prima continuano a fare film o televisione, le donne rappresentano ancora meno del 10% dei registi italiani, una percentuale significativamente inferiore a quella di altri paesi europei.
Uno studio del 2018, DEA (Donne E Audiovisivo), condotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha riportato «discriminazioni di genere nell’assunzione e nella retribuzione, condizioni di lavoro precarie, difficoltà nell’accedere a ruoli dirigenziali e posizioni prestigiose». Ciò significa che «un progetto diretto da una donna» scrive Ilaria De Pascalis «richiede un maggiore impegno per trovare finanziamenti molteplici, e probabilmente avrà un budget inferiore».
Insomma, per tornare alla domanda sottintesa di Cecilia Mangini, il cinema delle donne spesso, come ai suoi tempi, è «minor cinema» (un cinema di minoranza) come ha proposto la studiosa americana Allison Butler prendendo in prestito il concetto di littérature mineure di Gilles Deleuze e Félix Guattari, ovvero una letteratura prodotta da una minoranza in una lingua dominante. Come spiega Butler:
Questo saggio consiste in un estratto con significativi adattamenti dal mio libro Wandering Women. Per un’analisi approfondita dei film citati si veda: L. Di Bianco, Wandering Women. Urban Ecologies of Italian Feminist Filmmaking, Bloomington, Indiana University Press, 2023. L’intervista a Cecilia Mangini è stata condotta dall’autrice, a Roma, il 22 dicembre 2018.
Un rapporto del 2015 della European Women’s Audiovisual Network (EWA Network) indica che tra il 2006 e il 2013 in Austria, Croazia, Francia, Germania, Svezia e Regno Unito il 21% dei film è diretto da donne. Cfr. I. De Pascalis, ‘La ricerca DEA-Donne e Audiovisivo’ in L. Buffoni (a cura di), We want cinema. Sguardi di donne nel cinema italiano, Venezia, Marsilio, 2018, p. 262.
Ibidem.
Cfr. G. Deleuze, F. Guattari, Kafka: Toward a Minor Literature [1985], trad. in. di D. Poland, London and Minneapolis, University of Minnesota Press, 1986.
)