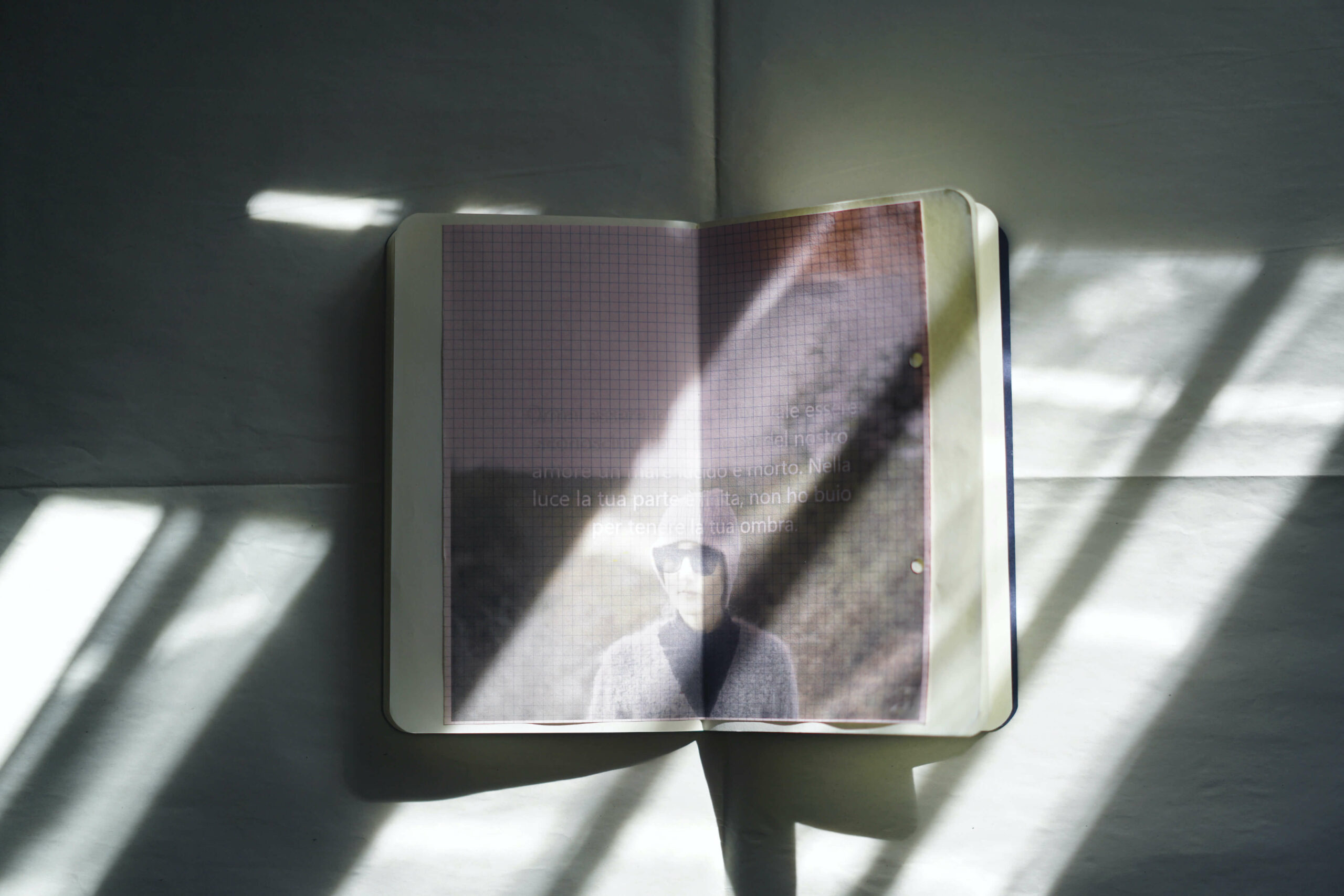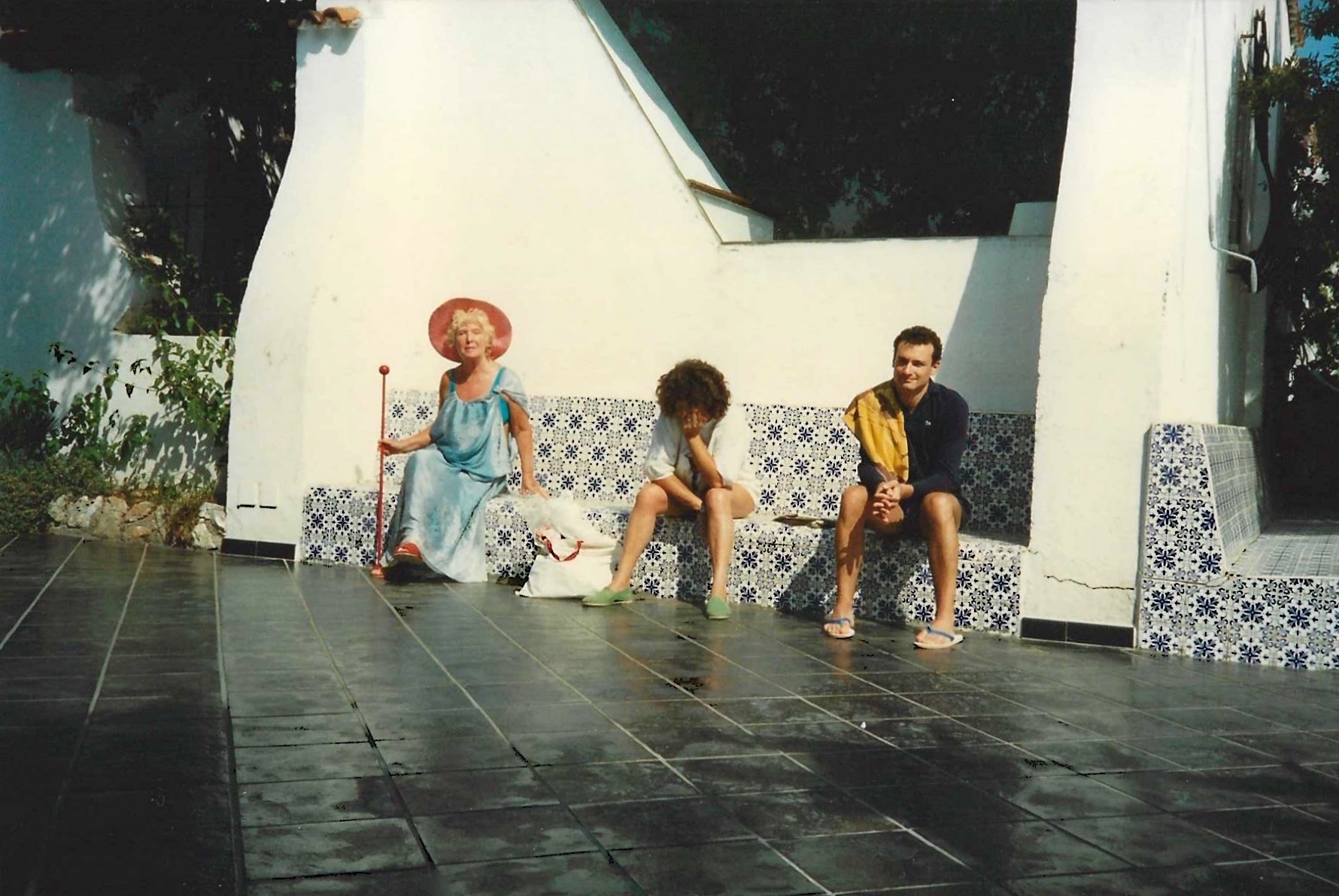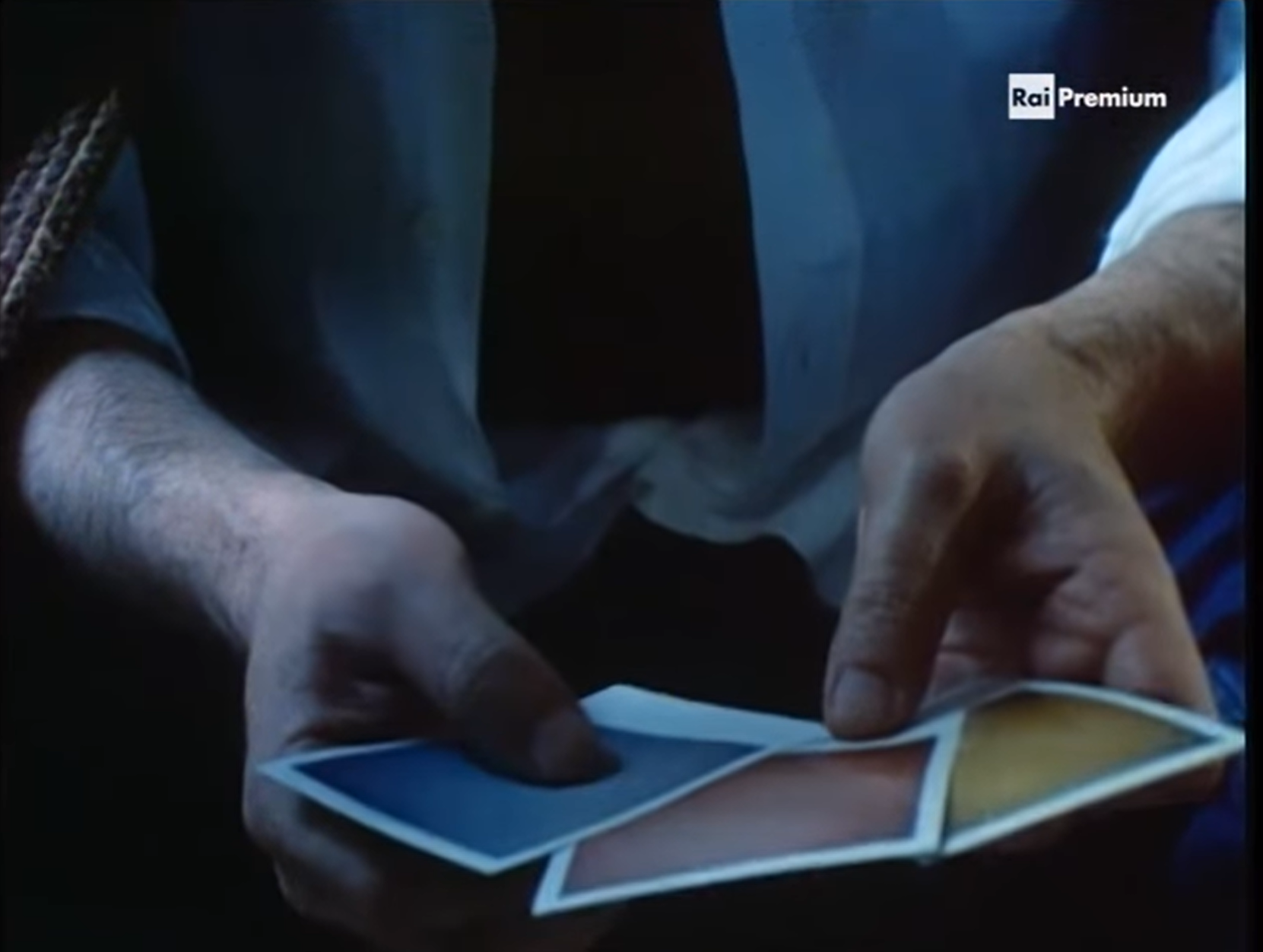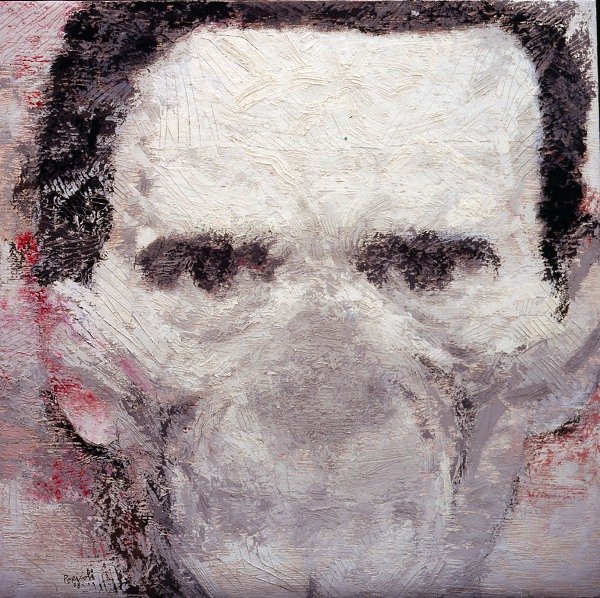La visività come motore dell’opera di Calvino è stata più volte messa in rilievo sia dall’autore sia dalla critica, insieme al quadro intermediale che orienta costantemente la sua attività narrativa e saggistica. Nella recente selezione dei suoi scritti intitolata significativamente Guardare, Marco Belpoliti enuncia già in copertina tutti i campi con cui Calvino entra in dialogo: Disegno, cinema, fotografia, arte, paesaggio, visioni e collezioni. Il rapporto con il cinema, in particolare, è diventato materia di diversi libri dal 1990 a oggi.
Lo scrittore per primo ha tracciato le coordinate della sua esperienza cinematografica in Autobiografia di uno spettatore che introduce nel 1974 la raccolta di quattro sceneggiature di Fellini. Riattivando la memoria dell’adolescenza, ci racconta che il cinema hollywoodiano classico ha rappresentato per lui un itinerario di formazione all’insegna dell’«evasione», dello «spaesamento», dell’immersione in un mondo altro rispetto a quello di tutti i giorni, non importa se pieno di «mistificazione» e «menzogna».
I. Calvino, Guardare. Disegno, cinema, fotografia, arte, paesaggio, visioni e collezioni, a cura di M. Belpoliti, Milano, Mondadori (Oscar Moderni), 2023. Si intitola L’occhio di Calvino il libro che Belpoliti pubblica nel 1996 per Einaudi. Al 2008 risale il volume di Maria Rizzarelli, Sguardi sull’opaco. Saggi su Calvino e la visibilità (Acireale-Roma, Bonanno).
L. Pellizzari (a cura di), L’avventura di uno spettatore. Italo Calvino e il cinema, Bergamo, Pierluigi Lubrina, 1990 (nuova edizione ampliata: Artdigiland 2015); V. Santoro, Calvino e il cinema, Macerata, Quodlibet, 2011; D. M. Zazzini, Il cinema per me era tutto il mondo: Italo Calvino spettatore, Teramo, Galaad, 2022.
I. Calvino, ‘Autobiografia di uno spettatore’, in F. Fellini, Quattro film, Torino, Einaudi, 1974, pp. IX-XXI; ora in I. Calvino, Guardare, pp. 151-167.
)