L’invenzione di sé impegna Betti per tutta la vita, fin dall’arrivo nella capitale, a soli vent’anni, con alle spalle un tormentato rapporto con le proprie radici e con la città di Bologna. È lei a edificare e a sfruttare i diritti della sua immagine pubblica, con una perentorietà inaspettata, che rivela la predisposizione verso gli ingranaggi della macchina dello spettacolo.
1.1. Ero tutta costruita
Non ho mai avuto pause nell’inventare il mio personaggio, dalla mattina alla sera. Mi sono inventata anche il vestito. Non avendo i soldi, io non avevo vestiti, però me li sono inventati, una specie di uniforme e via che andavo: un vestito nero col colletto bianco, la calzamaglia, il pullover nero per la scena. Ero tutta costruita, ma da me stessa. Nessuno mi aveva mai messo le mani addosso per costruirmi. Non è mai stato possibile. Me lo sono costruita io, da sola.
L. Betti, ‘Bisogna nuotare nel forse’, intervista a cura di R. Chiesi, Cineforum, 437, agosto-settembre 2004, p. 58.

Laura Betti in un fotogramma di Che cosa sono le nuvole?, di Pier Paolo Pasolini (1968)
Restando immune da ogni forma di manipolazione, Betti sceglie liberamente a quale modello corrispondere, grazie a un innato anticonformismo e a una spregiudicatezza che non restano inosservati. Il suo primo personaggio presenta caratteristiche immediatamente riconoscibili, ancorché misteriose, e sembra garantirle un effetto di lunga durata, come annota opportunamente Roberto Chiesi.
Il primo personaggio si identifica nella Laura Betti giovane, seducente, autoironica, libertina, spregiudicata, provocatoria, trasgressiva per la divertita inclinazione al turpiloquio e per ciò che voleva lasciar intendere della propria vita privata. Il suo corpo era scattante e felino, la sua falcata le valse il soprannome di “giaguara”.
R. Chiesi, ‘Una maschera selvaggia e dolorosa. L’attrice di cinema’, Cineteca speciale, 2005, p. 12.
L’aneddoto relativo all’epiteto di «giaguara» è la chiave di volta dello statuto divistico di Betti, perché da una parte rinvia alla sua indomabile tensione performativa, a quella «ferocia felina» che avrebbe caratterizzato molti ruoli, dall’altra invece evoca il clamore delle cronache mondane, la protervia con cui lei amava ‘darsi in pasto’ ai paparazzi. Due diverse testimonianze illuminano questa doppia tensione, e ci consentono di cogliere la necessaria complementarietà fra dimensione artistica e riverberi mediatici.
J. Risset, ‘Ricordo di Laura Betti’, Prove di drammaturgia, XII, 1/2006, p. 9.
Lei diceva che le era stato dato il soprannome per il passo che aveva. Attraverso questo passo potevi sentire che prendeva il volo al galoppo nella foresta, nella jungla, e non si sapeva dove poteva arrivare. Diceva, a chi negli ultimi anni le chiedeva l’origine di questo nome, che questa falcata non l’aveva più perché si era appesantita e anche di questo appesantimento diceva che era successo dall’1 novembre 1975, cioè dalla data di morte di Pier Paolo Pasolini. Da allora, diceva, «ho triplicato il mio corpo per resistere».
Ibidem. Conversando in radio nell’aprile del 2002 con Claudio Liccoccia, Laura Betti conferma l’origine del soprannome, raccontandosi a strappi ma con grande lucidità. L’intervista si inserisce all’interno della rubrica Pezzi da 90 e, come si intuisce dal titolo Il poeta e la giaguara, propone una sorta di omaggio doppio a Pasolini e alla sua musa. La conversazione si può ascoltare a questo link: http://www.raiplayradio.it/audio/2015/11/Pezzi-da-90-EXTRA—Il-poeta-e-la-giaguara-e9e5db74-11c9-40b2-bc8f-91b82bdf6f76.html [ultimo accesso gennaio 2020].
Jacqueline Risset, nel suo commosso Ricordo di Laura Betti, non si limita a recuperare l’eziologia del soprannome ma giunge a descrivere l’intensità della presenza dell’attrice, la sua frenesia insaziabile, e con esse la centralità del rapporto con Pasolini, in grado di incidere perfino sul suo sbilanciamento corporeo, nell’ osmosi dialettica fra vicinanza/leggerezza e distacco/gravità. Al di là dell’aneddoto, ingrediente essenziale nella biografia di Betti, qui conta il riconoscimento di un tratto fisico destinato a incidere il carattere, nonché a suggerire trame e traiettorie delle «personagge» da lei interpretate. Più che per la «mangusta» Vanoni, il soprannome la giaguara incarna infatti una tensione performativa che si ritrova nella maggior parte delle sue apparizioni, tanto in scena quanto sullo schermo. È quel che accade, per esempio, in Italie magique di Pier Paolo Pasolini, uno dei testi raccolti in Potentissima signora per la regia di Mario Missiroli. In questo atto unico, che Betti non esita a definire «in anticipo sui tempi e sulle mode», la sua presenza si articola secondo precise direzioni di senso, giocate sulla frizione fra mimica corporea e verbalità, fra la pura afasia della danza e l’ossessione per i calembours. Trasformata dall’immaginazione pasoliniana in una sorta di «Italia Liberty», Betti occupa la scena con forti accenti patetici e un sorprendente dinamismo gestuale, di cui purtroppo restano poche tracce ma che rappresenta senza dubbio uno dei vertici della sua avventura teatrale. La grazia en travesti di questo potente «spettacolo volante» anticipa le movenze e gli sguardi delle figure cinematografiche che mostreranno di lì a poco– come vedremo nella seconda sezione di questo studio – l’inclinazione promiscua del corpo, della voce e del gesto, nonché tutta la sua «innocenza animalesca».
La categoria della «personaggia» viene elaborata all’interno della critica femminista con l’intenzione di sottolineare l’eccedenza e il carattere imprevisto di alcune figure romanzesche, in grado di scardinare l’ordinaria stereotipia nella rappresentazione di ruoli e soggetti di donne. Per un inquadramento della questione si vedano: N. Setti, ‘Personaggia, personagge’, Altre modernità, 12, 2014, pp. 204-213; M.V. Tessitore, ‘L’invenzione della personaggia’, Altre modernità, pp. 214-219. Tale categoria è stata adottata in modo fecondo anche in riferimento al cinema e alla drammaturgia, grazie all’impegno e alla determinazione delle animatrici di FASCinA – Forum Annuale delle Studiose di Cinema e Audiovisivi.
L. Betti, Il poeta e la giaguara, radio intervista a cura di C. Liccoccia, 2002.
Potentissima signora andò in scena per la prima volta al teatro La Ribalta di Bologna il 5 dicembre 1964. La regia era firmata da Mario Missiroli mentre la drammaturgia era di Alberto Arbasino, Billa-Billa, Furio Colombo, Massimo Dursi, Augusto Frassineti, Gaio Fratini, Francesco Leonetti, Carlo Levi, Fabio Mauri, Alberto Moravia, Leda Muccini, Goffredo Parise, Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Patroni Griffi, Enzo Siciliano, Umberto Simonetta, Saverio Vollaro, Rodolfo Wilcock. I testi sono stati pubblicati nel volume Potentissima signora, Milano, Longanesi, 1965.
L. Betti, ‘Bisogna nuotare nel forse’, p. 61.
P.P. Pasolini, ‘Italie magique’, in Id., Teatro, a cura di W. Siti, S. De Laude, Milano, Mondadori, 2001, p. 2651.
S. Rimini, ‘Corpo di bambola: Laura Betti e lo straniato divertissement di Italie magique’, Studi Pasoliniani, 4, 2010, p. 53.
J. Nacache, L’attore cinematografico [2003], trad. it. di C Rossi, Mantova, Negretto Editore, 2012, p. 61.

Laura Betti in un fotogramma di Omaggio a Laura Betti, di Donata Gallo (2012)
Su un altro asse, rispetto al discorso di Risset, si pone Enzo Siciliano, al quale si deve probabilmente il merito di aver colto, sebbene in un rapido ritratto, l’anomalia del profilo di stella di Betti, il suo desiderio di «fare notizia», la vivace compromissione con il côté della cronaca mondana.
L. Betti, Teta Veleta, Milano, Garzanti, 1979, p. 58.
Correva già la svolta degli anni Sessanta. Laura Betti era sui rotocalchi «la giaguara»: caschetto di capelli platino, gli occhi tirati dal trucco come due virgole verso le tempie. […] La sua scena era non solo il teatro, ma anche la strada: sua, come una regina, via del Babuino, dove abitava. […] Aveva inventato un nuovo tipo di glamour: un modo diverso di essere prima donna, facendo uso d’una tecnica shock per attirare su di sé l’attenzione dei cronisti: la lusinga e l’insulto. Questo era il suo volto in pubblico; in privato, l’autoironia non le consentiva una coatta fedeltà al proprio cliché.
E. Siciliano, Vita di Pasolini, Firenze, Giunti, p. 271.
La dimensione sociale dell’artista, la rete delle sue amicizie e le intermittenze del suo «carattere del cazzo» rappresentano uno dei capitoli più effervescenti della sua avventura, perché raccontano allo stesso tempo la persona e la diva, intrecciando luci e ombre, emozioni e bagarre. La maggior parte di quanti la conobbero e la frequentarono insiste nel sottolineare l’ambivalenza affettiva di Betti, le oscillazioni fra stati d’animo opposti, che spesso rendevano problematico il confronto. Tra le testimonianze più vive si ricordano quella di Goffredo Fofi («Non era facile Laura Betti, carattere “di merda”, insopportabile fino a risvegliare nei più miti un istinto omicida, e un minuto dopo amica tenerissima»), a cui fa eco ancora Enzo Siciliano («Era famosa per le liti violente, con chiunque, e improvvisi trascorsi amorosi»), anche se forse, più di tutti, Gian Luca Farinelli riesce a cogliere nel segno di una personalità controversa:
M. Missiroli, ‘Era un’accanita lettrice che creava’, Cineteca speciale, p. 43.
G. Fofi, ‘Una giaguara nella dolce vita. La cantante’, Cineteca speciale, p. 8.
E. Siciliano, Vita di Pasolini, p. 271.
Come un’atleta dei sentimenti, spostava sempre più in alto l’asticella dei rapporti umani, mettendo alla prova quotidianamente le amicizie, la fedeltà, la chiarezza degli obiettivi comuni. […] Ospite meravigliosa, cuoca leggendaria, era capace di ferire le persone in modo irreparabile. Maestra nel mettere a nudo i punti deboli delle persone sapeva colpirle con una freddezza disumana. Con lei nulla era banale.
G.L. Farinelli, ‘Tutto era facile e difficilissimo’, Cineteca speciale, p. 4.
Le asprezze, di cui era certamente capace, obbediscono in realtà a un’indole malinconica e severa, condita da un sagace umorismo, che riservava innanzitutto a se stessa («è facile essere umoristici e divertenti sul conto degli altri. Ma su se stessi, no, è difficile. Laura aveva un senso dell’umorismo formidabile e rideva di se stessa per prima»). A ben guardare infatti perfino le malizie più sottili potevano essere il frutto di un crudele gioco delle parti, se è vero quel che testimonia Mario Missiroli, cogliendo fino in fondo la sua attitudine al paradosso: «l’alone di follia di alcuni suoi comportamenti era tutta una finzione. La follia era un ricciolo in più».
M. Monicelli, ‘Rideva di se stessa per prima’, Cineteca speciale, p. 44.
M. Missiroli, ‘Era un’accanita lettrice che creava’, Cineteca speciale, p. 44.
1.2. La Betti fa sempre cose marginali
La voce di Laura non smentisce i giudizi degli amici ma contribuisce ad alimentare il mito della ‘bella scontrosa’, del resto «la contraddizione è l’unico modo possibile per vivere o farsi vivere». Contravvenendo alle riserve dello stesso Pasolini, secondo il quale le interviste sarebbero un atto volgare di industria culturale, Betti si concede spesso ai giornalisti, ingaggiando una lunga battaglia con la società dello spettacolo e le sue civette. Dagli anni del suo debutto (i primi Cinquanta) fino al successo veneziano con Teorema (1968), si convince che questa disponibilità alla chiacchiera possa essere il viatico per incrementare la sua star persona («Io sono già famosa. Voglio dire nel senso che il mio nome sta sui giornali con anche delle fotografie»); in un secondo tempo invece – dal cuore degli anni Settanta fino alle soglie della sua scomparsa – le dichiarazioni affidate alla stampa hanno il tono dell’autoconfessione, condita come nel suo stile da punte di graffiante ironia; oppure dell’invettiva, quando al centro del discorso compaiono il fantasma di Pasolini e il rebus della sua morte. In ogni caso, perfino nel modo di interpretare la recita dell’intervista, Betti manifesta un’originalità fuori dal coro, che corrisponde a quanto accade sulle tavole dei palcoscenici.
L. Betti, ‘L’attore ideale per il regista? Uno sgabello’, in Cinema italiano. Ma cos’è questa crisi?, a cura di M. Monicelli, Roma- Bari, Laterza, 1979, p. 36.
Il poemetto Una disperata vitalità, contenuto nella raccolta Poesia in forma di rosa (Milano, Garzanti, 1964), è il luogo in cui con maggiore evidenza Pasolini tenta di demolire l’ipocrisia di certo giornalismo culturale, spesso votato a facili etichette, piegato agli strilli della cronaca e dunque incapace di cogliere lo spessore dei processi in atto nella società del suo tempo. La vanità delle pose di una stampa qualunquista e superficiale viene stigmatizzata con forza nella emblematica sequenza della Ricotta (1963) in cui viene messa in quadro l’intervista del giornalista Tegliesera al regista/Welles, che non a caso lo sbeffeggia recitando alcuni versi di Poesia in forma di rosa. Nonostante le forti resistenze nei confronti del sistema della comunicazione italiana, Pasolini continuò a offrirsi in pasto ai media, assecondando la sua vocazione alla parresìa e alimentando altresì la sua aura divistica.
L. Betti, Teta veleta, p. 54.

Laura Betti in un fotogramma di Omaggio a Laura Betti, di Donata Gallo (2012)
Il suo talento cristallino, forgiato nel fuoco di una passione selvaggia, la porta a frequentare nel primo lungo tratto della sua carriera quelli che De Monticelli definisce «gli scomparti minori dell’attività dello spettacolo»; il teatro-canzone, il cabaret sono il suo raggio d’azione, lo spazio in cui ha modo di manifestare l’attitudine all’azzardo, il senso della provocazione e il lampo di un’intelligenza fuori dal comune. L’esordio al fianco di Walter Chiari nella rivista I saltimbanchi (Milano, dicembre 1954) viene ricordato con accenti misti, tipici della sua disposizione autobiografica, secondo la quale ogni atto contempera gioie e dolori.
R. De Monticelli, ‘Non sono più i tempi di forzano’, Il Giorno, 11 agosto 1965.
Per una prima ricostruzione delle stagioni teatrali di Betti si veda S. Casi, Le sfide di un’attrice diversa. L’artefice teatrale, Cineteca speciale, pp. 18-21
Ero cresciuta nella cultura jazz, mi piaceva moltissimo, il jazz bianco, avevo i miei modelli e via che andavo, la Sarah Vaughan… La rivista con Walter, «I Saltimbanchi», fu molto divertente, aveva un pubblico enorme, enorme, quattro-cinquemila persone come ridere, e mi impressionava. È stata anche la prima volta che ho cominciato a cantare davanti ad un pubblico così vasto. Dietro le quinte andò malissimo perché io e Aroldo Tieri ci siamo tirati dei cazzotti in testa, insomma un putiferio… però è stato anche molto divertente.
L. Betti, ‘Bisogna nuotare nel forse’, p. 59. In un’altra intervista aggiunge alcune dettagli relativi a questa esperienza che chiariscono la precarietà con cui Betti mosse i primi passi nel mondo delle scene: «Feci una rivista, I saltimbanchi, perché Lucia Bosè vide che non c’avevo na’ lira, avevo due braccialettini, ma erano andati via subito… […] Tutti erano stufi che io andassi in giro a cercare se qualcuno mi faceva da mangiare, allora m’hanno fiondata dentro questa rivista di Walter Chiari ed era molto carina…» (L. Betti, ‘«Avevo una doppia vita»’, intervista a cura di R. Chiesi, Cineteca speciale, p. 30).
Le liti nel backstage sono l’indizio di un temperamento irriducibile che non offusca però le sue doti canore («cantava splendidamente, ma non lo sapeva e non le interessava per niente il problema»), messe in luce per un’intera stagione, sebbene strette in una piccola parte. Al termine di un ciclo senza dubbio effervescente Betti si accosta al teatro di prosa, che resterà per qualche anno un tappeto di fondo, con partecipazioni significative nella compagnia di Lilla Brignone e Gianni Santuccio; nessun ruolo di primo piano, in verità, ma non mancano incontri significativi come quello con Luchino Visconti. Con la sua proverbiale schiettezza tornerà a riferire dell’avventura teatrale con lui, in termini che lasciano trasparire una nota di rimpianto, per quello che sembrò già allora un appuntamento mancato:
L. Betti, ‘Autoritratto’, Cineteca speciale, p. 48.
Visconti era durissimo, ed era un attore straordinario, riusciva a interpretare in maniera sublime tutti i ruoli, tutti i personaggi. Ma soffriva molto in quel periodo per i suoi problemi sentimentali ed era sempre ubriaco. Mi trattò malissimo, cosa che non gli perdonai, ma, al tempo stesso, rimanemmo molto amici. Mi consigliò di cambiare il mio cognome da “Trombetti” in “Betti” e io lo feci.
L. Betti, ‘Bisogna nuotare nel forse’, p. 60.
La Mercy Lewis de Il crogiulo di Miller non fu dunque un’interpretazione memorabile ma Visconti impresse comunque una svolta significativa alla carriera dell’attrice, suggerendo un nome d’arte destinato a risuonare a lungo tra le pagine mondane e le vie del jet set.
Lo spettacolo, per la regia, le scene e i costumi di Visconti, debuttò al Teatro Quirino di Roma il 15 novembre del 1955 in prima nazionale. Nel cast, tra gli altri, Lilla Brignone (Elisabeth Proctor), Gianni Santuccio (John Proctor), Adriana Asti (Mary Warren), Tino Buazzelli (rev. Parris).
Questo episodio viene ricordato con brio anche in Teta veleta, tra gli appunti di un fantomatico ‘diario romano’ che, incrociando mirabilmente realtà e finzioni, descrive l’escalation della diva: cfr. L. Betti, Teta veleta, p. 43.
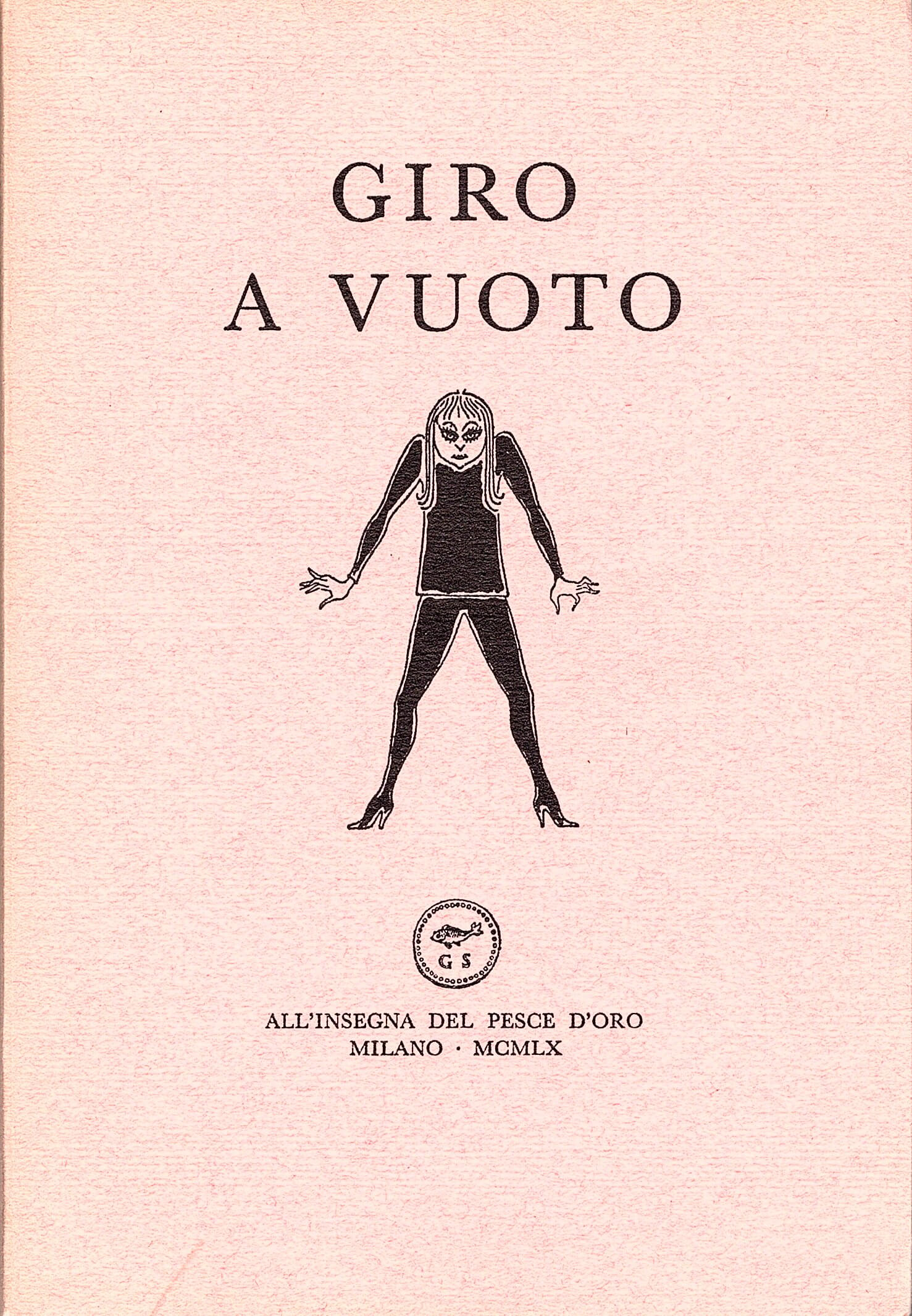
La copertina del volume Giro a vuoto (1960)
Il percorso di Betti dentro l’orizzonte della scena italiana appare, come sottolinea opportunamente Casi, «spurio e ambiguo, sostanzialmente eccentrico rispetto alla codificazione spettacolare degli anni Cinquanta». Con grande protervia, infatti, alterna prosa e canzoni, convinta che i recital richiedessero una tensione performativa notevole e che «la canzone fosse più difficoltosa del teatro». Nel muoversi con disinvoltura, e quasi senza soluzione di continuità, fra due linguaggi, Betti lancia consapevolmente la sua sfida alle istituzioni e giunge infine a incarnare un nuovo modello, l’attrice intellettuale, portatrice di una diversità assoluta e senza compromessi. Il primo passo in tale direzione è rappresentato dalla partecipazione al radiodramma di Dino Buzzati Una ragazza arrivò, titolo quasi profetico se si pensa che appena pochi mesi più tardi – nel gennaio del 1960 – sarebbe esploso con il recital Giro a vuoto il fenomeno-Betti. Le ragioni di questo successo vanno attribuite alla sensibilità e all’intuito dell’artista, pronta a lanciare anche in Italia, sulla scorta dell’esempio francese, il genere della canzone d’autore. Come è facile sospettare non mancano dichiarazioni in prima persona su queste esperienze, utili a ricostruire da una prospettiva senz’altro privilegiata (ancorché di parte) un momento saliente dell’avanguardia nostrana, purtroppo poco indagato nonostante la qualità delle proposte.
S. Casi, ‘Le sfide di un’attrice diversa’, p. 19.
L. Betti, ‘Bisogna nuotare nel forse’, p. 60.
Si tratta in effetti di una commedia musicale radiofonica, trasmessa in Rai il 28 aprile del 1959 con la musica di Gino Negri e la regia di Alessandro Brissoni: la presenza di dialoghi surreali e atmosfere misteriose sembra richiamare ‘situazioni’ à la Ionesco, perfettamente aderenti al timbro vocale di Betti e al suo temperamento d’attrice.
A Roma, una volta diventata cantante di cabaret, lei ha avuto l’idea di far scrivere le sue canzoni da degli scrittori… Contrariamente alla Francia, in Italia non esisteva una tradizione di canzone intellettuale e io ho voluto introdurre questo genere. Dapprima mi sono rivolta a Moravia che avevo appena conosciuto – nutriva molta curiosità nei confronti delle persone che arrivavano a Roma – e fu una specie di rivoluzione: i testi di certe canzoni urtavano il perbenismo dell’epoca».
L. Betti, ‘Madame Betti à Paris’, intervista a cura di J. Chavanne, Ex libris, 4 ottobre 1989 (trad. di R. Chiesi)
Fu un’idea mia quella di cantare testi degli scrittori che amavo. Cominciai a chiedere loro i testi e a pensare a questo spettacolo insieme a Filippo Crivelli. È stato il putiferio perché tutti gli scrittori volevano partecipare. Moravia non capiva nulla di metrica… […] Pier Paolo invece era bravissimo. Le difficoltà con la metrica di Moravia determinarono il coinvolgimento di musicisti contemporanei perché, se no, non se ne sarebbe venuti a capo. Andai alla Biennale di Venezia e incontrai Strawinski che mi regalò alcune pagine di battute musicali.
L. Betti, ‘Bisogna nuotare nel forse’, p. 60.
Il conservatorismo tipicamente provinciale di certa cultura italiana viene spazzato dall’azzardo canoro di Betti che, grazie alla complicità degli amici intellettuali, confeziona un repertorio spiazzante, per la crudezza dei temi e la grinta del suo timbro. Giro a vuoto è un ordigno a orologeria che Betti governa con stupefacente autorevolezza, sia sul piano dell’invenzione che su quello esecutivo. Il passaggio veneziano in Biennale viene accompagnato da una nota molto lusinghiera di Fedele d’Amico, che coglie l’ampiezza tonale della sua voce e il karma della sua fisicità:
Dopo il debutto milanese, al Teatro Gerolamo il 27 gennaio del 1960, Giro a vuoto diventa ‘seriale’ e annovera altre tre edizioni: Giro a vuoto n. 2 (Venezia, Festival della Musica, 3 ottobre 1960); Giro a vuoto n. 3 (Milano, Teatro Gerolamo, 18 novembre 1962); un’edizione francese che va in scena a Parigi, al Théâtre de l’Athenée, il 17 dicembre del 1961. La formula del one-woman-show convince pubblico e critica per effetto della trascinante prova d’attrice di Betti, straordinaria nel dar corpo a figure e timbri diversi. I testi delle canzoni contano firme prestigiose del calibro di Arbasino, Bassani, Cederna, Flaiano, Fortini, Mauri, Moravia, Parise, Pasolini e Soldati, mentre le musiche erano affidate, tra gli altri, a Fiorenzo Carpi, Luciano Chailly, Gino Marinuzzi Jr., Piero Piccioni e Piero Umiliani. Il Teatro Gerolamo diventerà nel cuore degli anni Sessanta il luogo di elaborazione della cosiddetta «canzone milanese», genere peculiare sia in riferimento alla codificazione di una specifica accezione di ‘milanesità’ sia rispetto al fenomeno della musica intellettuale.
Di qualità eccezionale sono i suoi arnesi d’interprete: dizione infallibile, voce pieghevole a ogni occorrenza, musicalità capace di giocare sul millimetro; e poi un fisico dotato, dalla testa ai piedi, della vocazione istrionica più lampante. […] In Laura Betti ogni mezzo gode della più spavalda autosufficienza: voce, parola, inflessione musicale e gesto, luci e ombre, durezze e legature, possono giocare l’una contro l’altra, illuminarsi e contraddirsi e commentarsi e prendersi in giro a vicenda, con un assoluto controllo del risultato finale. […] La Betti materializza i fatti scenici in tono non veristico, ma distaccato e allusivo, cospargendoli di scaltre lacune; e li contrappunta al resto con acrobatica leggerezza.
F. d’Amico, ‘Laura Betti’, in La Biennale di Venezia. XXIII Festival Internazionale di musica contemporanea, a cura di E. Zanetta, Giardini di Castello, 18 giugno-16 ottobre 1960.
Il «brivido dell’anomalia» bettiana è tutto qui, nel piglio camaleontico della sua performance, nell’attrito fra «durezze e legature», nella autarchica declinazione dei mezzi espressivi, frutto insperato di un’esperienza da autodidatta, spinta da un infallibile istinto di artista-saltimbanco. A d’Amico non sfugge la complessità della macchina attoriale di Betti, sostenuta da un’impalcatura vocale vivacissima e da un catalogo di gesti variegato e imprevedibile, sempre mobile e sorvegliato, nonostante gli impulsi del carattere. La sorpresa maggiore però, a detta del critico, consiste nella volontà di non accontentarsi del repertorio esistente, e in un certo senso già collaudato; Betti sceglie di crearne uno nuovo e «nelle pericolose sorti di quest’idea s’è compromessa fino in fondo». Al di là di ogni considerazione squisitamente musicale, quel che rende sovversivo il progetto di recital come Giro a vuoto è la prossimità con i nodi sintomatici della persona Betti, la stretta dipendenza tra le figure evocate dalle canzoni e il corpo-voce che le interpreta, che dà loro sostanza. In altre parole, è la forza del suo personaggio, re-inventato dagli amici scrittori, a risultare vincente, a imprimere un marchio unificante all’intera operazione.
Ibidem.
Loro si trovavano bene perché gli davo molto materiale umano mio, che fosse falso o vero o creato. La formula consisteva anche nel parlare sempre di me, che invece non ero affatto io… Fortini era stato travolto da me, collaborai a lungo con Fabio Mauri, che era bravo ed era un mio amico profondo. Flaiano era al di fuori di quel gruppo e lo presi io.
L. Betti, ‘Bisogna nuotare nel forse’, p. 60.
Betti afferma nel milieu della canzone d’autore una vocazione metamorfica singolare che, come si vedrà nei prossimi capitoli, verrà sublimata nel versante della recitazione cinematografica. I testi di Giro a vuoto consegnano con spiccata evidenza le maschere di una soggettività eccedente, che tende alla dissimulazione, ammicca e provoca, potendo far leva sul timbro graffiato della voce e su posture ora scarne ora eccitate. L’effetto moltiplicatore delle diverse identità bettiane è una ricca galleria di tipi femminili, la cui mappa, a detta di Fofi, richiamerebbe il modello distillato da Cederna all’interno della rubrica Il lato debole, anche se le personagge di Betti si fanno portatrici di un ardore e di una marginalità ben più articolate di quanto non traspaia dalle pagine de «L’Espresso». Le donne incarnate dalla cantante-performer vivono traumi e rivincite, aggressioni e rifiuti, sono immerse nelle contraddizioni della società del boom, che comincia a mostrare le prime crepe. Senza voler indulgere in complicate analisi sociologiche, e rivendicando (a differenza di Pasolini) un fiero orgoglio di classe, Betti si diverte a rompere gli argini dell’ipocrisia e si fa interprete di una doppia istanza: lo sdoganamento di certi tabù (il sesso su tutti) e la colorita rivendicazione di uno spensierato principio di evasione, condito certo da impegno e pruriti ideologici ma in fondo libero da precise marche politiche. La buffoneria clownesca di certi testi (di Mauri, di Arbasino, dello stesso Moravia) fa il paio con la poesia dei margini de Il valzer della toppa o Macrì Teresa detta Pazzia (di Pasolini e Umiliani) a riprova dell’«esplosiva estroversione» degli stili. Il corpo a corpo con l’intellighenzia nostrana produce dunque uno spettacolo dirompente, destinato a segnare la storia del costume e della canzone italiana; Giro a vuoto, lungi dall’essere semplicemente un colorato carosello, restituisce tutti gli elementi che avrebbero caratterizzato la prima stagione di Betti, «quella della musica (e del teatro che ne derivava, della musica “applicata” al teatro». La coesistenza di registri recitativi diversi, la qualità del timbro e della grana della voce, la varietà delle inclinazioni mimetiche fanno già parte del bagaglio di Betti, che riempie il palco grazie a una presenza scenica invidiabile, maturata quasi senza sforzo.
André Breton fu tra i primi ad accorgersi di tale forza comunicativa, a restare incantato di fronte a quella vertigine di parole, ritmi e fiati che Betti era in grado di dispensare durante il recital.
Per Fofi la cantante prova a trasformarsi in un «alfiere di democrazia, di combattente, potremmo dire pensando a tempi subito successivi, panelliana, più che pasoliniana» (G. Fofi, ‘Una giaguara nella dolce vita’, p. 10).
Cfr. C. Cederna, Il lato debole, a cura di G. Borghese, A. Cederna, Milano, Feltrinelli, 2000
G. Fofi, ‘Una giaguara nella dolce vita’, p. 11.
Jacopo Tomatis inquadra in modo puntuale e rigoroso il contesto in cui matura l’esperienza musicale di Betti, richiamando da un lato «l’origine salottiera e di divertissement» delle collaborazioni degli scrittori, dall’altro la sostanziale novità delle canzoni, che mostrano toni ironici, satirici, risentiti, declinando forme che Carpitella definisce «neo-realistiche e urbane» (D. Carpitella, Conversazioni sulla musica: 1955-1990, Firenze, Ponte alle Grazie, 1992, p. 161). In ogni caso l’aspetto più rilevante riguarda «l’essere concepite per il palcoscenico, per essere interpretate da un performer ben preciso in un contesto teatrale, e non (almeno da principio) per essere incise, edite a stampa o interpretate da altri» (J. Tomatis, Storia culturale della canzone italiana, Milano, il Saggiatore, 2019, p. 258).
G. Fofi, ‘Una giaguara nella dolce vita’, p. 8.
Non potevano mancare fra le dichiarazioni di Betti, avvezza al piacere della divagazione e dello scarto, accenni all’incontro con Breton, raccontato con punte di giocosa malizia: «A Parigi, André Breton aveva perso la testa. Abitava attaccato al teatro dove recitavo e veniva tutte le sere facendo schiamazzi tremendi. Io, che non lo avevo riconosciuto, credevo mi stesse prendendo in giro, invece si divertiva follemente! Era una persona deliziosa, me lo ricordo molto bene!» (L. Betti, ‘Bisogna nuotare nel forse’, p. 61). Sempre in dialogo con Chiesi, Betti torna sull’episodio francese: «Una sera cominciai a sentire delle risate tremende. Chi è questo qui? Chiamo il direttore: “Scusi, c’è uno stronzo che mi prende in giro. Lei stia attento e domani sera, me lo cacci fuori. Non voglia avere in sala un cretino così”. La sera dopo, quello ritorna: era André Breton. Si era pazzamente innamorato di me (ride). […] Poi scrisse un pezzo meraviglioso, dico meraviglioso perché mai nessuno mi ha scritto o detto cose che ha scritto lui» (L. Betti, ‘«Avevo una doppia vita»’, Cineteca speciale, pp. 30-31).
Se non avete mai visto la tempesta in un bicchiere d’acqua (non nel senso figurato, ma in quello fisico del termine) cosa aspettate? Cosa aspettate per andare ad applaudire Laura Betti in quello che lei chiama, sicuramente per antifrasi, il suo «giro a vuoto»? […] Il suo repertorio e l’uso mimico che ne fa, hanno il dono di far appassire quasi tutti gli altri. C’è tutto ciò che cova di meravigliosamente eccessivo in una testa ben fatta di giovanissima leonessa che affronta la miseria specifica del nostro tempo e le risponde con la provocazione e la sfida. Se ognuna delle sue canzoni la avvolge a meraviglia è perché lei fa corpo con essa, è perché questa canzone si è forgiata nello stesso fuoco che la abita.
A. Breton, ‘Laura aimantée’, Candide, 15 febbraio 1962, ora in Cineteca speciale, p. 75 (trad. it. di R. Chiesi).
L’aggettivo «calamitante» («aimantée»), scelto da Breton per definire la performance di Betti, è una formula di pathos, l’indizio di un’espressività controllata ma potente («lei tiene la scena […] appagandosi senza la minima eclissi di sé nella luce d’eclisse che è lo scrigno delle sue metamorfosi»), cui si aggiungono altre notazioni che lasciano intendere quanto fosse talentuosa quella «giovanissima leonessa».
Tra il debutto milanese di Giro a vuoto e la tournée francese del recital, Betti trova l’occasione di sperimentare un’altra forma di teatro ibrido, a mezza via fra prosa, mimo e danza: il 14 maggio 1961 debutta al fianco di Carla Fracci al Teatro Eliseo di Roma nell’opera di Brecht e Weill I sette vizi capitali, per la regia di Luigi Squarzina, le coreografie di Jacques Lecoq e le scene di Renzo Vespigani. L’interpretazione di Anna I è una sfida ardua per chi, come lei, era abituata per lo più a essere la padrona assoluta dei mezzi e dell’impianto della recita; l’articolazione della drammaturgia in quadri, e la necessità di accordarsi con Anna II per mantenere la complementarietà dei ruoli su cui si fonda il progetto di Brecht e Weill, metta alla prova i suoi vezzi e le impone un controllo diverso. Le note critiche di Fabio Mauri, spettatore avvertito e amico leale dell’attrice, restituiscono tutte le insidie di questa interpretazione ma consentono altresì di rimarcare l’unicità della liaison fra persona e artista.
Ibidem.
La Betti fa il teatro come un pittore dipinge le sue visioni, sulla propria pelle cioè, uscendone da ogni debutto proprio allo stesso modo: più povera e più forte di prima. Questa fatica quotidiana le ha sviluppato delle doti che speso fanno di lei non un’attrice, ma lo spettacolo in persona. Altre volte, come la sera di questa prima, queste stesse doti le hanno giocato un tiro mancino. Sciolta e sonora alla prova generale, la sera appariva rigida e troppo energica, quasi disperata. Si vedeva la sua abitudine a misurarsi da sola con il teatro, e a sostenere sulle spalle scena, platea e tutto, isolata; la faceva sentire fuori, presa in un combattimento orchestrato e collegiale come quello di un’opera a più parti, a ruoli combinati che si intersecavano secondo il disegno prima dell’autore e poi del regista. La Betti non aveva abbastanza nemici, e non poteva affrontarli di petto, doveva star ferma mentre i mimi sculettavano, non poteva correre in prima fila a vincere di prepotenza, come è solita fare. Sembrava una giocatrice di catch ad una gara di ricamo.
F. Mauri, ‘Mimi ballerini e cantanti per sette peccati’, Sipario, 182, giugno 1961, p. 31.
Se nei primi minuti dello spettacolo Betti appare dunque «fuori misura», per la sproporzione fra ‘sé’ e le altre figure, sulla distanza «si tende a vederla sempre più a fuoco, nel suo carattere stabilmente ambiguo, nella sua rabbia e feroce saggezza». Pur con qualche esitazione sul piano dell’ensemble, la prova vocale resta però superba e non a caso Betti si lascia scappare un dettaglio che sottolinea, una volta di più, la qualità della sua dizione canora: «Ho fatto fior di opere di Brecht e Weill, ho fatto I sette vizi capitali senza microfono e Milva l’ha fatto col microfono». La phoné della giaguara non ha bisogno di amplificazione, trova nel tessuto verbo-sonoro delle canzoni di Weill la possibilità di un estroso rispecchiamento, e così il rapporto con le impegnative atmosfere dei song prosegue, sotto l’attenta direzione di Bruno Maderna. La consonanza con questi testi è piena, Betti sa di poter agire su un doppio asse, vocale e performativo, e in tal modo corrobora il modello di attrice-intellettuale, votandosi a un genere che rimane in scia con le «canzoni di rottura» degli scrittori. Non sfugge a Massimo Mila l’intensità di tale investimento:
Ibidem.
L. Betti, ‘«Avevo una doppia vita»’, p. 31.
Cfr. Kurt Weill 1933-1950, cantato da L. Betti, diretto da B. Maderna, presentato da R. Ledy, LP 33 giri, Ricordi, 1963.
U. Eco, ‘La canzone nuova’, Sipario, 222, dicembre 1963, p. 31.
Se si va a vedere in che consiste, propriamente, la differenza del canzonettista dal cantante lirico, si scopre ch’essa consiste in una qualità che dovrebbe essere indispensabile anche ai cantanti d’opera […]. Questa qualità è il rispetto della parola, il gusto della parola. La recitazione sensata ed espressiva. E questa qualità è l’arma per niente segreta, ma eccezionalmente affilata ed efficiente con cui Laura Betti riesce a spuntarle nel suo coraggioso e commovente impegno con Kurt Weill. […] È un vero talento filologico quello che le permette di mettere in primo piano la parola, non solo nel senso fisico di farla percepire, ma di realizzare attraverso la parola cantata il dramma che è il nocciolo di ogni canzone. […] È questo senso delle parole, questa ragione della collera che Laura Betti sa esaltare.
M. Mila, ‘Laura Betti e Kurt Weill’, in Laura Betti in “Canzoni di Kurt Weill”, Teatro comunale di Firenze – XXVII Maggio Musicale Fiorentino, 1964.
1.3. Cambiar pelle
All’altezza dei primi anni Sessanta si consuma una sorta di corto circuito nella carriera di Betti; teatro, canzone e cinema si intersecano sempre di più e la sua popolarità cresce, per l’effetto combinato dei successi artistici e del clamore legato alle sue ‘piazzate’ mondane. È un periodo di grande fervore, in cui l’artista non si risparmia e vive in una recita perenne, saldando con grande disinvoltura esperienze e codici differenti in un unico piano sequenza. L’apparizione nella lunga notte de La dolce vita assume un rilievo simbolico forte, perché fissa la postura espressiva alla persona, generando la scintilla che la porterà a indagare e a contraddire il rapporto fra verità e finzione.
Per un colorito ritratto a tutto tondo di Betti si suggerisce il lavoro documentario di Paolo Petrucci, che accuratamente raccoglie materiali d’archivio e testimonianze di amici riuscendo a comporre un profilo mosso e accattivante: cfr. La passione di Laura, regia di P. Petrucci, Cinecittà Luce, 2012.

Laura Betti in un fotogramma de La dolce vita, di Federico Fellini (1960)
Tale frizione emerge chiaramente nella rievocazione affabulante di Teta veleta, che offre un piano di lettura della sua esistenza certamente straniato, ma ricco di implicazioni:
Tanto i soldi ce li hanno solo quelli famosi che fanno il cinema che è ricco per conto suo e l’intellettuale può lavorarci solo se sa recitare se stesso, ma in genere non lo sa per via di Freud e quindi non può. Per fortuna che Fellini lo sapeva benissimo chi sono io così mi ha fatto fare la Dolce Vita e quindi vuol dire che quella che è lì sul telone sono io e basta.
L. Betti, Teta veleta, p. 58.
In effetti la Laura che partecipa ai riti orgiastici di casa Steiner risponde perfettamente al profilo bettiano; l’abito nero col colletto bianco richiama la mise con cui solitamente l’attrice viene ritratta, ammiccando a una linea virginale di solito contraddetta dalla sua sboccata loquela, ma è soprattutto la sua presenza scenica ad aderire al personaggio di se stessa, per quell’atteggiamento un po’ borioso, a tratti urticante che riserva a molti degli invitati. Tullio Kezich, che racconta di averla incontrata proprio sul set felliniano, sintetizza in modo icastico l’analogia tra figura reale e personaggio:
Era come la vedrete nel film, con la sua divisa di battaglia: l’abito nero, il gran collettone bianco a punta, le braccia cariche di metalli e di amuleti, un faccione rotondo maltrattato da un trucco pesantissimo e incorniciato alla meglio da una pioggia di capelli biondastri. Quasi un costume da maschera da personaggio fisso di una certa commedia umana. Un Gian Burrasca revisionato da Freud.
T. Kezich, ‘La cantante della dolce vita’, in Giro a vuoto, risvolto di copertina.
Dispettosa, «ironicamente diplomatica», insiste nel punzecchiare il povero Marcello, che alla fine reagisce ma «Laura-grillo parlante non si lascia schiacciare né dagli insulti che le rivolge, né dal liquore che le versa in faccia».
Il senso, spudorato, di questa auto-finzione è affidato a un’altra dichiarazione di Betti, che ribadisce la contiguità fra il piano dell’esistenza e i riflessi dell’arte, e soprattutto conferma il tratto rissoso del suo temperamento, l’oscillazione fra collera e generosità:
R. Chiesi, ‘Una maschera selvaggia e dolorosa’, p. 13.
L’episodio della Dolce vita era nato da un episodio reale, una litigata spaventosa che facemmo io e Marcello a tavola, sotto gli occhi di Federico e Pier Paolo, avvenuta in nome di che non lo abbiamo mai saputo. Io e Marcello avevamo un ottimo rapporto. Eravamo amici. Scoppiò questa specie di bomba. E a Fellini quella scena piacque e la ricreò per il film.
L. Betti, ‘Bisogna nuotare nel forse’, p. 65.
Betti riesce dunque a recitare ‘senza copione’ anche con Fellini, un autore con cui non provò mai una grande affinità, per ragioni che contrastavano palesemente la sua vocazione alla disobbedienza, o forse meglio all’anarchia. Non potendo schivare le domande sulla sua prima importante esperienza sul set, Betti sceglie la via della sincerità e offre l’ennesima riprova del suo essere «disorganica a una certa macchina cinematografica».
«Insomma, per la verità, c’è sempre stata in me una percentuale di anarchia enorme, ma queste cose non è che le approfondisci, le passi al volo, le vivi così, alla giornata…» (L. Betti, ‘Bisogna nuotare nel forse’, p. 58).
G. Bertolucci, ‘Portava la sua statura di protagonista nei vestiti stretti del carattere’, Cineteca speciale, p. 41.
Il primo film importante fu La dolce vita.
Sì, ma non è che sia entrato nella mia vita… (ride) Mi sono un po’ divertita, ma niente di più. Anche se Fellini mi era molto simpatico… non sarebbe mai stato un artista a me affine, perché preferiva lavorare con attori che ricoprivano il ruolo di oggetto… e ridurre me ad oggetto, non è proprio possibile! (ride).
L. Betti, ‘«Avevo una doppia vita»’, p. 32.
Sebbene l’incontro con Fellini non sia da annoverare tra quelli destinati a cambiare il corso della sua avventura, è pur vero che questo ruolo esplicita il paradosso di attrice di Betti, ovvero la necessità di continuare ad alimentare la propria romanza, a esibire infinite variazioni di una stessa maschera. Nessuno era in grado di imporle una ‘parte’, se non – come vedremo – Pasolini, e tutti i registi con i quali si trovò a lavorare sottolineano l’indipendenza del suo modo di recitare, l’esigenza di essere artefice della propria arte.
Tale necessità viene espressa a chiare lettere da Betti, per quell’abitudine alla confessione (e alla contraddizione) che garantisce l’accumulo di una ricca quantità di documenti, utili alla ricostruzione del ‘livello intimo’ di impronta meldolesiana.
Cfr. C. Meldolesi, Pensare l’attore, a cura di L. Mariani, M. Schino, F. Taviani, Roma, Bulzoni, 2013.
Se tu fai l’attore in un certo modo, ti manca qualcosa. Io ho dovuto fare la regista di me stessa, ho dovuto farmi nascere. Non è mica stata un’impresa da niente… Io avevo in mente un personaggio e volevo essere quel personaggio. Non volevo affatto che il pubblico mettesse il naso nei miei affari. Sapevo che, per non permettergli di mettere il naso, io dovevo dare in pasto al pubblico un personaggio che gli piacesse…
È lì che è cominciata questa saggia… divisione, che poteva portarmi alla mancanza di saggezza. Invece Bologna mi ha aiutato, il buon senso… e sono andata avanti bene, con questo sistema. Avevo veramente una doppia vita. Ma l’ho avuta sempre. Avevo questa capacità di amministrare una vita e un’altra vita…
L. Betti, ‘«Avevo una doppia vita»’, p. 32.
Si intitola Libertà è resistenza lo spettacolo di cui Betti cura la regia nel 1965, incastonando testi antifascisti, lettere di partigiani e canzoni nel tentativo di dare alla forma-cabaret degli accenti diversi, politicamente impegnati, pur restando in scia con quanto sperimentato nel già menzionato Potentissima signora. Nei panni della «soubrette sofisticata per palati fini» si sente evidentemente a proprio agio ed è lei stessa a mettersi al mondo attraverso un’azione sapientemente maieutica, che a quell’epoca non lasciava presagire neanche l’ombra di un rimpianto. Betti nel cuore degli anni del boom, in cui si complicano gli ingranaggi dello star system italiano e l’industria culturale insiste nel consolidare stereotipi grazie alla forte pressione dell’immaginario cinematografico, offre al pubblico e ai media un modello diverso, che accende curiosità e interessi.
Lo spettacolo è andato in scena la Teatro comunale di Ferrara il primo maggio del 1965.
S. Casi, ‘Le sfide di un’attrice diversa’, p. 10.
Per un inquadramento del contesto produttivo e divistico italiano si veda almeno M. Landy, Stardom Italian Style: Screen Performance and Personality in Italian Cinema, Bloomington, Indiana Up, 2008.
Il tuo personaggio era fuori da ogni schema: non eri una vamp, ma giocavi con alcuni stereotipi della vamp, univi la seduzione e un’ironia che poteva essere giocosa e cattiva, una fantasia follemente carnevalesca, ma al tempo stesso, rivelavi spesso un temperamento tragico, una malinconia più nascosta…
Sì, non c’era nessuna come me [ride].
L. Betti, ‘Bisogna nuotare nel forse’, p. 58.
Lo scarto tra ferocia e innocenza era probabilmente il suo trucco migliore, una concessione tributata soprattutto al cinema, anche se al fondo di certe canzoni si poteva trovare il rombo del dolore più sordo. In scena riusciva a essere sottile come una lama, perfino nelle parti leggere, tanto era avvezza al brivido dell’incerto, alla finzione di ogni sentimento.
Alla lunga però qualcosa si incrina. In una delle ultime interviste rilasciate prima della sua scomparsa emerge un’altra verità, che ci consente di chiudere il cerchio delle sue contraffazioni.
È stato difficile essere per te quel personaggio nella società dello spettacolo di allora? Mi riferisco all’anomalia che un’attrice fosse anche autrice di se stessa…
A nessuno era dato saperlo. A quei tempi veniva dato così, ero così e così dovevo essere. Di questa doppia immagine, sempre allo specchio, ne ho un po’ risentito dopo. Avrei voluto, non dico fare marcia indietro, ma almeno riposarmi dal rischio di essere un’altra da me stessa, anche perché rischi di perdere il filo. Non voglio arrivare a Pirandello… ma la domanda «Chi sono?» finisce per imporsi alla mente, prima o poi. Questa è una domanda perturbante, ma qualche volta viene.
Ivi, pp. 58-59.
Arrivare a Pirandello invece è necessario per cogliere tutta l’amarezza con la quale l’attrice, negli ultimi mesi della sua esistenza, guarda e commenta la sua immagine pubblica, ritrovando la spietata evidenza di una maschera nuda. L’invenzione gioiosa di un personaggio-paravento, in sintonia con i propri vizi ma forse troppo spudorato, finisce per imbrigliare la mutevolezza del suo spirito, per vincolarla a un cliché che stenta a riconoscere. La sfrontata irriverenza che ha sempre accompagnato le sue dichiarazioni, quel senso di provocatoria esibizione di sé, si sciolgono di fronte alla consapevolezza del prezzo che si paga nel pensare di poter essere autentica in un mondo che si nutre di inganni.
Gli attori dotati di una forte personalità creano quasi inevitabilmente l’identità di un personaggio che viene identificato con il loro io reale e spesso si sovrappone prepotentemente ad ogni ruolo che interpretano. Quali rapporti hai con il personaggio Laura Betti, come lo vedi dall’esterno? Ti corrisponde, è una maschera, oppure è una figura che t’infastidisce?
M’infastidisce. Adesso m’infastidisce. Perché è una pura creazione di me stessa. È mia. Allora l’avevo inventato per non dare al pubblico, alla gente, alla stampa, niente di mio. Avevo deciso io stessa questa tattica [sorride] e fu una decisione molto imprudente perché si finisce per pagarla, in seguito. Infatti sono rimasta condannata da certe etichette e luoghi comuni che mi rompono l’anima e mi fanno venire i nervi, e molto. Certe etichette che non mi appartengono, però, ormai sono entrate a far parte del mio personaggio. Me le sento tirare in faccia. […] Questa è una cosa che adesso mi pesa moltissimo, anche perché a volte vorrei veramente uscirne fuori. Ma il marchio si è talmente cristallizzato.
Ivi, p. 57.
Il gusto per la contraffazione e la beffa si trasforma via via in contrappasso, la inchioda a giudizi e interpretazioni spesso viziate dalla confusione fra realtà e apparenza, natura e menzogna. Da qui l’abbandono a un senso di sconfitta e di rimpianto, in cui si stenta a riconoscere la tempra della giaguara. Nell’espressione «rompere l’anima» si legge il carico di una sofferenza non artefatta, quasi senza rimedio, mentre il processo di ‘cristallizzazione’ sembra non essere più reversibile e imporre uno stigma indelebile.

Laura Betti © Archivio Mario Dondero
Soltanto una persona aveva colto fino in fondo la sua anomalia, percependo la fragilità celata dietro lo scostamento asimmetrico fra persona e personaggio («Chi lo sapeva molto bene questo, era Pier Paolo»): a lui avrebbe dedicato ogni premura, oltre le regole dell’illusione. Per il resto, l’unico antidoto possibile non poteva che essere continuare a recitare, perché «fare l’attrice significa cambiar pelle, ma anche dimenticare, rimuovere ciò che si è e non piace essere».
Ibidem.
L. Betti, ‘«Sono stata femminile soltanto con Pasolini»’, intervista a cura di A. Del Bo Boffino, Amica, 19 giugno 1979, p. 25.
)












