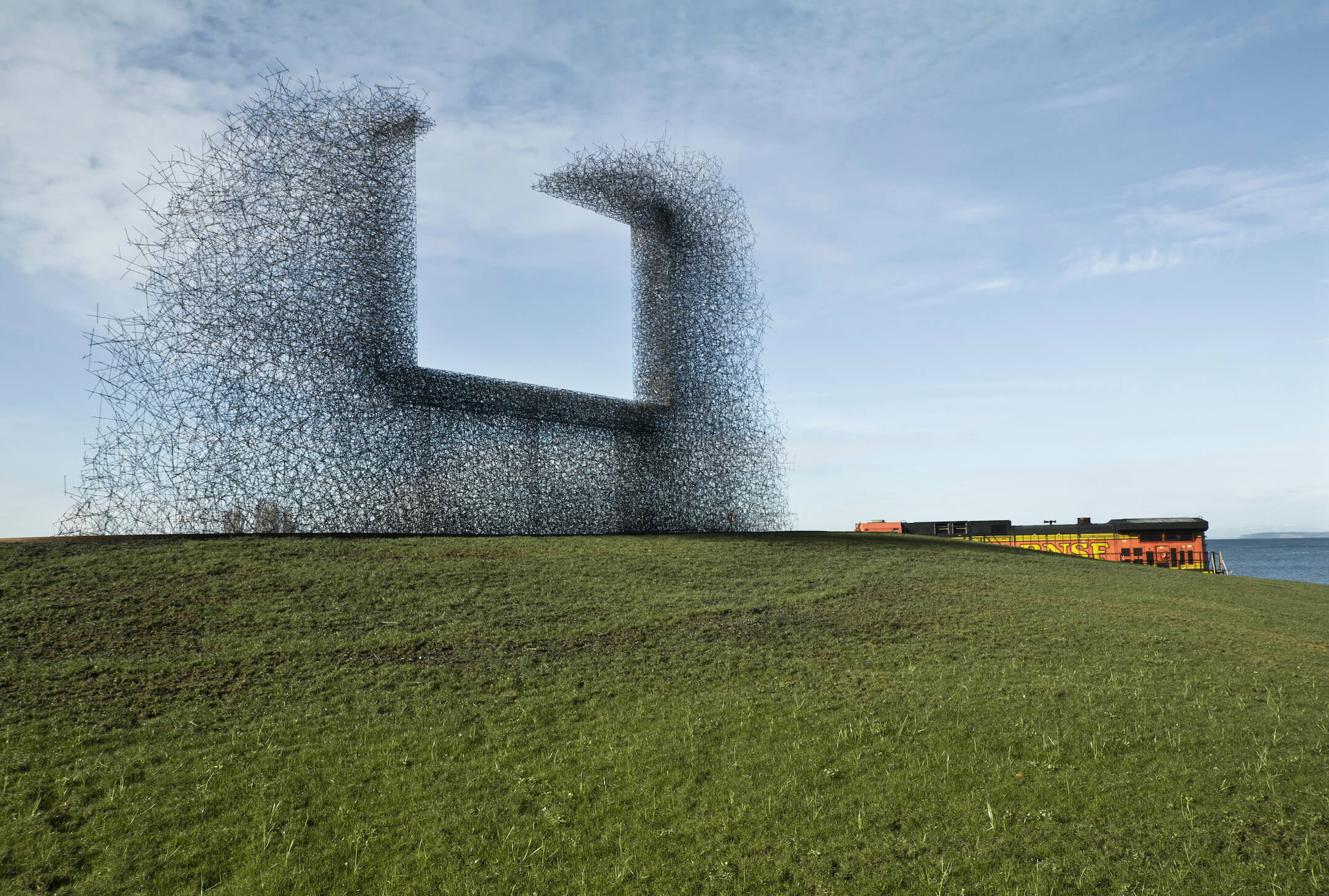From up here the Earth is beautiful,
without borders or boundaries.
Jurij Gagarin
From up here the Earth is beautiful,
without borders or boundaries.
Jurij Gagarin
Per via di un radicale allontanamento del punto di osservazione sulla Terra,[1] la celebre frase di Jurij Gagarin sull’impossibilità di vedere i confini territoriali dallo spazio ha fin da subito generato una collettiva, e non priva di invidia, fascinazione per quell’inedito belvedere e per l’illusione, da esso suscitata, di un mondo senza frontiere. Nonostante questa prima testimonianza, si è comunque diffusa nel tempo la diceria secondo la quale da una tale distanza sarebbe comunque ancora possibile osservare a occhio nudo la Grande Muraglia Cinese. Nel 2003, è intervenuto l’astronauta cinese Yang Liwei a sostenere[2], pur non senza persistenti difficoltà, l’irrealtà di tale radicata credenza, a sua volta confutata da spiegazioni sul funzionamento dell’occhio umano.[3] Nonostante ciò, la persistenza di questa leggenda pare suggerire un’ossessione del genere umano per i confini, se non addirittura l’incapacità stessa di immaginare il suolo terrestre completamente privo di demarcazioni territoriali. Oggi, sempre più artisti e studiosi, muovendo figurativamente dallo stesso punto di vista di Gagarin e Liwei, ci invitano a «re-imparare ad atterrare sulla Terra»[4] come reazione a un epocale disorientamento politico-sociale, di portata simile a quello post-copernicano e kepleriano. Si tratta dello sconvolgimento suscitato dalla consapevolezza di essere, ormai da tempo, dentro l’Antropocene.
Su questa linea, il presente contributo intende ‘tornare sul nostro pianeta’, pur conservando un punto di vista alternativo sulle dinamiche centrali alla (presunta) nuova era geologica, ovvero interrogandole da quei luoghi tanto discussi perfino dallo spazio: i confini e le frontiere. Come si può evincere dall’ambivalenza semantica nel titolo di questo testo, l’atterraggio suscitato è metafora del duplice raggio d’azione su cui è imperniata la riflessione qui proposta. Accostare il tema dei confini e dell’arte a essi relativa, la Border Art, all’epoca antropocenica significa, infatti, muovere lungo un piano concreto, tangibile e, contemporaneamente, lungo uno più epistemico e meramente terminologico. In quanto arte eseguita da, su e a proposito dei confini geo-politici e concettuali,[5] la Border Art, dunque, consente di evidenziare, in maniera più o meno diretta, l’emergenza di una serie di problematiche d’impianto sociologico e ambientale di più immediato e pratico riscontro. Allo stesso tempo, essa agisce da perno analitico per interrogare il rapporto uomo-natura e, soprattutto, l’annoso dibattito sulla più adeguata denominazione dello stesso Antropocene.
Con l’obiettivo primario di sviscerare questo doppio binario, si propone allora una rilettura di alcune significative opere di Border Art, la cui analisi srotola un fil rouge intervallato da due nodi principali: il concetto di ‘traccia’ e quello di ‘mobilità’, a loro volta interconnessi. Tale percorso, infine, si inserisce, contribuendovi, all’interno della tesi, avanzata e sostenuta da Nail sull’importanza di spostare l’enfasi semantica del concetto ‘Antropocene’ verso un’idea di movimento e di adottare, al suo posto, il lemma ‘Kinocene’.[6] Dalle opere prese in esame emerge, d’altronde, come sempre più urgente, un’attenzione nei confronti di un’ontologia frontaliera instabile, consistente in uno slittamento verso una dimensione mobile dei confini, che pone inevitabilmente in dubbio la stabilità, la fissità e la linearità a essi spesso attribuita. Ciò non si manifesta solamente nell’ambito delle divisioni territoriali, ma anche nei limiti epistemici propri del rapporto tra uomo occidentale, natura e confini e, soprattutto, in quelli adottati per le definizioni di questa era geologica, laddove con ‘de-finizione’ si intenda già di per sé un atto di circoscrizione semanticamente declinato.
Occorrono alcune introduttive note di stampo teorico-metodologico sulle necessità interdisciplinari generate dall’adozione di una specifica sfera visuale come strumento per l’individuazione e la comprensione di dinamiche intricate e interconnesse quali appaiono quelle frontaliere e antropoceniche. Lo studio si imposta su alcune recenti prospettive umanistiche e culturali dei border studies d’impianto geografico e muove dall’attuale status quaestionis sulla Border Art, ancora carente di un’adeguata riconsiderazione nel contesto antropocenico. La sottomissione dei casi studio alle lenti analitiche offerte dalla border aesthetics[7] e dalla border wall aesthetics[8] sostiene la lettura interpretativa del genere artistico nel contesto dell’Antropocene che viene qui intrapresa. Coerentemente alla dimensione globale (per quanto diversificata nei suoi effetti locali) di quest’epoca, i casi-studio presi in analisi consistono in una selezione di opere provenienti da diversi contesti frontalieri internazionali. Tra essi, figurano principalmente quello a tratti murato tra Messico e Stati Uniti e le acque mediterranee, ma interessanti prospettive emergono anche dalla divisione tra USA e Canada. Equivalgono comunque tutti a paradigmatici teatri di una significativa commistione tra spazio naturale e sociale di cui le opere si servono in termini di site-specificity.
Conseguentemente, la struttura del testo risulta articolata in tre sezioni contenenti ognuna uno dei concetti-chiave con cui viene riletta la Border Art. Nella prima parte, che ha il ruolo di introdurre il panorama teorico entro il quale agisce la ricerca, si ripercorre la diatriba sulla denominazione ‘Antropocene’ e sulle esigenze di una decolonizzazione del termine, al fine di spiegarne le ragioni sottostanti e di approfondire le implicazioni di tale questione definitoria. Nella seconda parte, invece, si individua la traccia come metafora del rapporto tra uomo e natura in epoca moderna e ne vengono circoscritte alcune criticità. Nella terza parte, ci si concentra sulle questioni di mobilità come problema e punto di vista privilegiato per la comprensione del cosiddetto Kinocene, ‘l’epoca del movimento’,[9] in epoca post-moderna, per infine giungere ad alcune note e considerazioni conclusive alla luce dell’analisi condotta.
A cominciare dalle sue prime adozioni in ambito pubblico,[10] il sostanziale susseguirsi di terminologie proposte in alternativa alla parola Antropocene ha reso possibile riferirsi all’ultimo ventennio come l’epoca del ‘Neologismcene’.[11] Ognuna delle oltre cento possibilità lessicali coniate in questo ventennio risponde in maniera idiosincratica alle problematiche di volta in volta più care e urgenti alle discipline conianti le varie proposte.[12] In quanto indirizzato anche alla comprensione dei limiti dell’Antropocene come complesso concettuale, questo studio sostiene una lettura di tale fenomeno come costituente già di per sé un problema di bordering. Si tratta di intendere l’urgenza di individuare una parola adeguata come una questione ‘de-finitoria’,[13] secondo l’etimologia latina del lemma. In quest’ottica, l’atto del de-finire si fa, infatti, proiezione su di un piano linguistico-semantico di una pratica di circoscrizione territoriale e viceversa. In qualità di demarcazione tra qualcosa che sta ‘all’interno’ o ‘all’esterno’ di qualcos’altro, definire implica tracciare e fissare un insieme di limiti e punti estremi in uno spazio/tempo, reale e tangibile o ipotetico e concettuale a seconda di ciò che si definisce. Per ragione di un’alternanza e di una ridistribuzione di concetti e nozioni storico-critiche da un lato e dall’altro della divisione semantica, le numerose declinazioni del termine Antropocene sono, d’altra parte, giustificate da ulteriori considerazioni relative al livello di de-limitazione cronologica del suo inizio e alle sue conseguenze. Ne sono prova le più note e datate proposte di Technocene,[14] Capitalocene,[15] Manthropocene e Northropocene,[16] White Supremacy Scene,[17] ecc.
Appare evidente che, pur arricchendosi di caratteri ora propri dei feminist studies, ora dei post-colonial studies o ancora degli studi di stampo marxista o sociale, tali esempi agiscono per lo più in maniera critica nei confronti dell’etimologia greca della parola “uomo”, ἄνθρωπος,[18] che intendono sostituire con una più specificatamente circoscritta. Il suo significato, infatti, poiché pregno d’universalità e totalità, sarebbe logicamente privo di una necessaria differenziazione sociale in termini di coinvolgimento attivo nell’innegabile trasformazione geo-morfologica del suolo planetario, della biosfera e, conseguentemente, nelle cause dell’attuale crisi climatica e ambientale. Giova, comunque, sempre ribadire la globalità degli effetti a lungo termine di tali cambiamenti, a prescindere dal grado di colpevolezza delle singole parti e — come dimostrato dalle più urgenti prospettive dell’environmental justice[19] — nonostante una marcata disparità di livello nell’intensità d’impatto socio-ambientale lungo le aree del pianeta. In altri e più sintetici termini, le conseguenze dell’Antropocene coinvolgeranno l’intero genere umano, seppur non tutte le società sarebbero colpevoli in egual maniera della sua esistenza e anche se non tutte ne vivranno le conseguenze con le stesse tempistiche e con il medesimo coinvolgimento. Va da sé che a questa distinzione sottende un confine e che numerose delle alternative riportate sono frutto di un processo di radicale trasformazione morfologica, carico di susseguenti mutazioni semantiche e consistente, in sostanza, nella sua decolonizzazione.
L’annosità del dibattito segnala già limiti e problemi impliciti all’applicazione di un processo de-finitorio alternativo nei confronti di un termine che da principio, come sostenuto da Davis e Todd, «[…] betrays itself in its name: in its reassertion of universality, it implicitly aligns itself with the colonial era».[20] Nell’assumere il suddetto grado di universalità come già di per sé indice di una dimensione coloniale, il processo decolonizzante dovrebbe, di conseguenza, operare in termini cronologici tramite l’individuazione di una data univoca per le scienze umane per l’inizio di quest’era. Traslando il dibattito su questo piano, le autrici concordano sull’Orbis Spike, un rintracciabile calo dei livelli di diossido di carbonio globali successivo al genocidio delle popolazioni indigene sudamericane e all’improvvisa crescita di alberi nelle terre da loro abbandonate.[21] La data corrisponderebbe per le autrici non solo a uno spostamento di beni e persone su scala planetaria senza precedenti, ma anche ai primi effetti visibili dell’epoca coloniale e del progetto occidentalizzante intrapreso dalle potenze europee in epoca moderna. Non si fa, tuttavia, menzione della relativa prossimità di questa datazione con il 1648, la data su cui i border studies concordano come limite cronologico con cui far coincidere la nascita del confine moderno. Eppure, esistono buone ragioni per ritenere fondamentale concentrarsi su questa vicinanza cronologica. Anzitutto, riportare l’attenzione su questo aspetto implica riconoscere il ruolo giocato dai confini nella cornice della colonizzazione. Difatti, si propone qui di leggere la mera prossimità temporale tra l’Orbis Spike e i trattati di Westphalia — con cui termina la Guerra dei Trent’anni e inizia una suddivisione del potere politico-giuridico su matrice di circoscrizioni territoriali — come un sintomo della mutata mentalità europea tra il XV e il XVI Secolo. La nascita dei confini in questo periodo equivarrebbe a uno dei più ampi gradi di quella che Amilhat Szary individua come la proporzionalità multi-scalare dell’atto politico e posizionale centro-periferico del framing.[22] Quest’ultimo, continua la geografa, è iscritto nel contemporaneo sviluppo di una forma mentis collettiva fondata sulla differenziazione in categorie scientifico-gnoseologiche.[23]