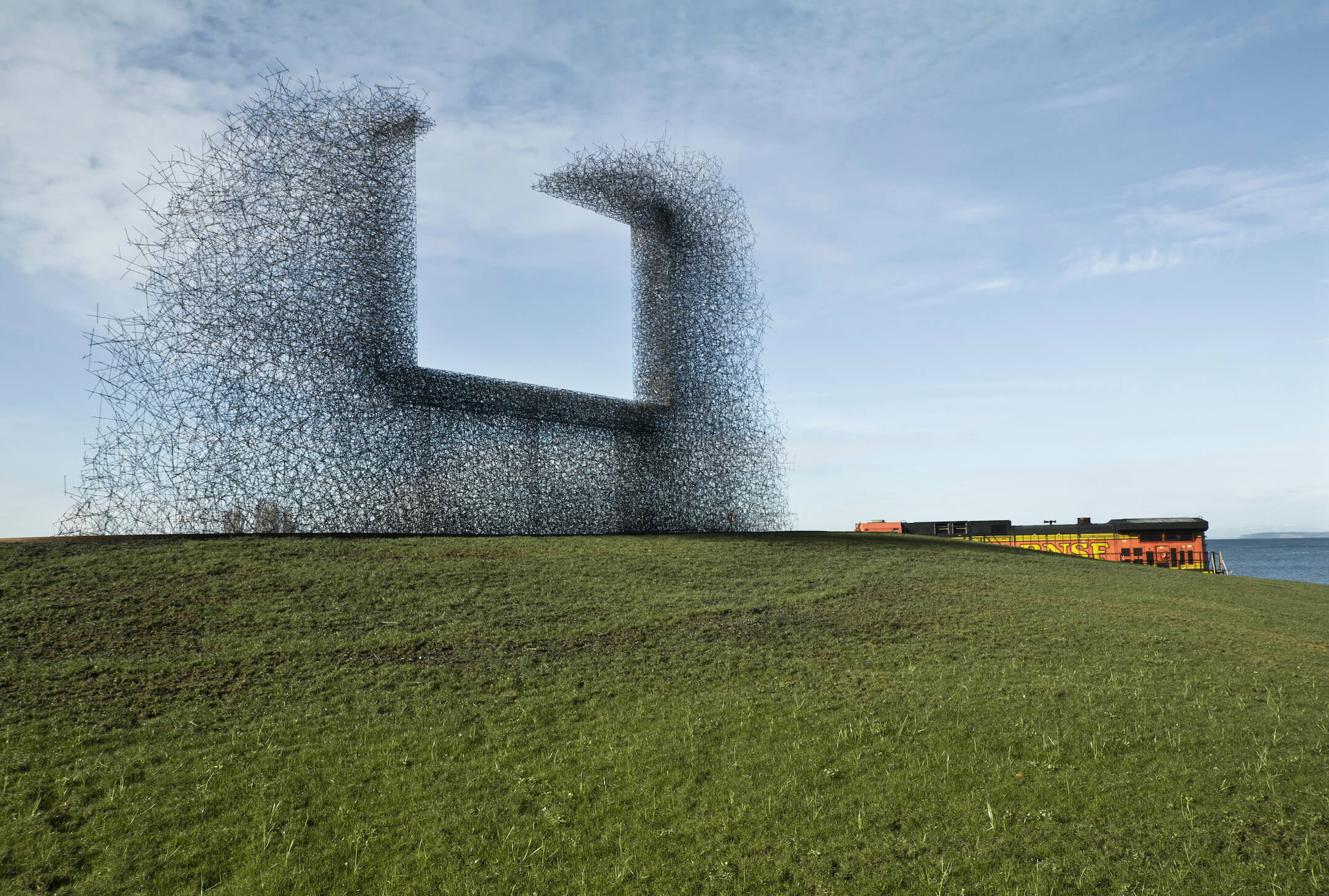La prolifica attività produttiva di Milo Rau è espressione diretta di un metodo che all’istinto per la sperimentazione di forme unisce l’attenzione del sociologo. Sintetizzando si potrebbe affermare che la sua prassi metodologica sia la ricerca antropologica e il modo migliore per rappresentarne gli esiti. Rubando da Bossart e dalla sua intervista al regista bernese il riferimento all’etnologo Clifford Geertz, potremmo indicare, in una proficua fluidità tra teatro e antropologia, la sua come una prassi di «descrizione densa», in cui «le forme di vita» acquisiscono corpo perché inscritte in un con-testo di cui ci si appropria solo attraverso partecipazione attiva e analisi interpretativa. La sua formazione come sociologo, il suo passato da attivista lo caratterizzano nel metodo e nella forma. Difatti il suo metodo investigativo-creativo, quand’anche persegua modalità tecniche di tipo documentaristico, non strumentalizza il materiale acquisito per una narrazione da reportage, piuttosto rappresenta «una sorta di guida alla lettura in senso politico dei racconti biografici degli attori. In tal modo gli aspetti più privati sono apparsi come metafora, come allegoria del sublime».
Sia chiaro però che l’attributo di regista sociale non si addice all’autore di Hate Radio. Infatti, se il dramma sociale per Szondi manifesta, nella sua costruzione scenica, non il microcosmo per il macrocosmo (principio simbolico afferente al dramma) ma la pars pro toto, tanto da «rappresentare drammaticamente le condizioni economico-politiche sotto il cui impero è caduta la vita individuale», e se il compito dei suoi autori è «mostrare i fattori che hanno le loro radici al di là della situazione singola e del singolo fatto, e che pure li determinano», ciò non può dirsi affine all’operato di Rau, il quale cerca di essere contemporaneamente «cronista e portatore di utopie». Non c’è determinismo illuministico nelle sue opere, né alcuna necessità di restituire una mimetica riproduzione del reale o di esporre teatralmente dinamiche sociali. Difatti non tratteggia mondi esemplari da cui trarre norme comportamentali, ma recupera dal panorama storico un evento per dedurne la sua caratteristica allegorica. Per questa ragione, quand’anche lavori ad opere di re-enactment si tratta pur sempre di una forma d’arte la cui realizzazione pone l’obiettivo di un disvelamento mai concluso nella riproposizione dell’atto in forma mimetico-documentaristica. The last days of Ceauçescus o Hate radio sono «re-enactment artistici», opere d’intelletto in cui gli eventi si mostrano secondo una realtà fittizia, una fantasmagoria sociale non per questo non reale; così come i suoi Trial (The Congo Tribunal, The Moscow trial o The Zurich trial) sono al contempo procedimenti fittizi e accadimenti. È nell’attenzione al dettaglio che si restituisce l’effetto di realtà. «Ma la modernità, a cui io aderisco, ricerca la precisione matematica, la costruzione della presenza: l’arricchimento quasi smisurato unito all’umile semplicità di una struttura sobria; la sostituzione dell’autentico con l’intelligenza di una forma emotiva creata ad hoc». Non si tratta mai di verità fattuale, ma esclusivamente di verità artistica, in cui la finzione non rende meno credibile la rappresentazione. «Questa è la ragione per cui il teatro si è sviluppato come forma d’arte: per mettere in opera la più naturale e la più fantasiosa delle abilità umane, quella di ricreare la realtà a partire da un immaginario sociale». Si parla sempre, dunque, di un’opera che punta, in una dialettica laboriosa tra l’immaginazione e la comprensione, tra le idee e la loro trasposizione, a realizzare qualcosa che sia vero, che diventi reale laddove per reale si intenda una struttura aperta. «Realismo non significa che si rappresenta qualcosa di reale, ma che la rappresentazione è essa stessa reale; significa produrre una situazione che porti in sé tutte le conseguenze del reale per i partecipanti, una situazione che sia moralmente, politicamente ed esistenzialmente aperta». Perché «il teatro non è altro che un ritorno molto concreto a questa semplice lezione aristotelica: tutto ciò che consideriamo come reale non è che una convenzione sociale». In linea di continuità con gli studi di Turner, il teatro è qui esperienza liminale, tra realtà e rappresentazione.
M. Rau, R. Bossart, ʻSono un postmoderno senza atteggiamento postmodernoʼ in Id., Realismo globale, Imola, Cue Press, 2019, p. 15.
M. Rau, R. Bossart, ʻNon c’è un come se nei miei progettiʼ, in Id., Realismo globale, p. 47.
P. Szondi, Teoria del dramma moderno, Torino, Einaudi, 2000, p. 52.
Ivi, p. 51.
Ibidem.
M. Rau, ʻCos’è l’umanesimo cinico?ʼ, in Id., Realismo globale, p. 45.
«Per me è fondamentale pensare al concetto di evento in senso kierkegaardiano, quindi come ripetizione: da un lato come ricordo di un evento dimenticato (in quanto traumatico, represso, oppure, all’esatto opposto, banalizzato e del tutto ritualizzato dalla politica memoriale); dall’altro come presagio luminoso di una futura realtà che non si è ancora compiuta, dunque come “memoria preventiva” di qualcosa che deve ancora essere fatto, che deve ancora avverarsi.» M. Rau, R. Bossart, ʻCom’è stato quando il primo proletario è apparso sulla scena?ʼ, in Id., Realismo globale, p. 53.
Sull’allegoria del sublime si rimanda al paragrafo 3 del presente saggio.
M. Rau, ʻThe Last Days of the Ceaçescus. Eziolamento e narrazione collettivaʼ, in Id. Realismo globale, p. 79.
M. Rau, R. Bossart, ʻNon c’è un come se nei miei progettiʼ, p. 47.
M. Rau, R. Bossart, ʻSono un postmoderno senza atteggiamento postmodernoʼ, p. 17.
M. Rau, ʻCos’è il realismo globaleʼ, in Id., Realismo globale, p. 31.
M. Rau, R. Bossart, Sono un postmoderno senza atteggiamento postmoderno, p. 17.
)